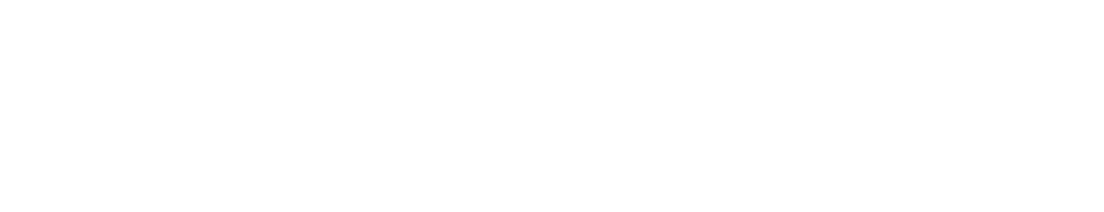Parigi, settembre 2021: uno dei produttori di scarpe sportive più noti al mondo, con sede centrale in Germania, incappa nei rigori dell’Autorità francese di controllo della pubblicità.
Cos’era successo? Nella propria comunicazione pubblicitaria, l’azienda aveva sostenuto che un proprio marchio di scarpe fosse prodotto al 50% con materiali riciclati. Secondo l’Autorità francese, l’affermazione era generica e non consentiva al consumatore di apprezzare esattamente il significato del messaggio essenziale che veniva comunicato (50% di materiale riciclato).
Quali in dettaglio le ragioni della contestazione formulata al produttore? La pubblicità mostrava una scarpa intenta a schiacciare una bottiglia di plastica vuota; sullo sfondo, si leggeva “Almeno il 50% di materiali riciclati; tutta la plastica utilizzata nella scarpa viene riciclata”. Secondo l’Agenzia francese, non era chiaro se fossero riciclati i materiali usati in produzione, o solo la plastica utilizzata in produzione dopo la fine dell’uso. Inoltre, veniva pesantemente contestata la correttezza del logo “End plastic waste”, considerato scorretto in quanto la plastica, pur in parte riciclata, era ancora ben presente in produzione.
Facciamo un passo indietro, per comprendere meglio i profili legali di questo genere di casi e la loro replicabilità nel contesto italiano.
Tradizionalmente, la pubblicità viene considerata come il regno dell’esagerazione e dell’iperbole, un po’ come se questi fossero difetti connaturati e inevitabili nello strumento pubblicitario, di fronte ai quali i consumatori sarebbero in qualche misura addestrati per evitare ricadute troppo pesanti a proprio danno.
Sul piano giuridico però le cose non stanno così: la pubblicità deve presentare determinati requisiti minimi di correttezza importanti affinché la comunicazione commerciale possa dichiarare od evocare “benefici di carattere ambientale o ecologico”.
Da tempo, anche in Italia, l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato ha iniziato ad occuparsi della tematica “pubblicità ingannevole”: nel 2012 ad esempio, quando un’inserzione pubblicitaria che vantava iperboliche qualità ambientali per delle bottiglie in plastica venne sanzionata per la “enfasi eccessiva rispetto alla reale portata dell’impegno ambientale della società”.
Più recentemente, il Regolamento EU 2020 sulla tassonomia definisce come ecosostenibile un’attività economica che:
1) contribuisce in maniera sostanziale a uno o più obiettivi ambientali;
2) non danneggia in modo significativo nessun obiettivo ambientale europeo;
3) è svolta senza violare i diritti umani.
Dunque, No Greenwashing” (green, “verde” + whitewashing, “riverniciare per coprire le imperfezioni”).
Come è possibile rispettare gli attuali requisiti obbligatori della pubblicità ecologica?
Quando si parla di “dati veritieri, pertinenti e scientificamente verificabili” occorre evitare, oltre alla diffusione di dati aziendali falsi, affermazioni che, per la loro genericità, possano essere agevolmente contestate attraverso una “prova contraria” (es: “emissioni zero”, “le emissioni più basse del settore”, ecc.).
Quando si parla invece di pertinenza (“comprendere chiaramente a quale aspetto del prodotto o dell’attività pubblicizzata i benefici vantati si riferiscono”) occorre non andare a caccia di farfalle.
Perché proprio le farfalle?
Negli anni 80 del secolo scorso, la compagnia petrolifera Chevron, per convincere i clienti della propria eccellente e complessiva sostenibilità ambientale, aveva realizzato diverse pluripremiate pubblicità televisive che mostravano i dipendenti della compagnia impegnati attivamente nella tutela di farfalle, tartarughe e altri animali ecologicamente significativi.
A seguito delle azioni giudiziarie intentate da associazioni ambientaliste, Chevron divenne la prima importante azienda accusata con successo di appropriarsi ingiustificatamente di un’immagine sostenibile, per allontanare l’attenzione dai propri impatti negativi sul pianeta.
Un fenomeno non isolato ma che ha oggi dimensioni notevoli. Come rilevato dall’indagine Europadirect il 1 febbraio 2021, circa la metà delle affermazioni “ecologiche” presenti nella comunicazione web delle aziende presenta un fondamento quanto meno discutibile.
Fuggire dal greenwashing significa rispondere ad esigenze di legalità e correttezza nella comunicazione commerciale ed all’interesse delle aziende ad evitare sanzioni e soprattutto inutili ed evitabili danni di immagine.
In un prossimo futuro, è anche possibile che, per le aziende del settore, il tema diventi rilevante sotto un profilo diverso da quello finora trattato: quello del cd. “sport-wash”. Di cosa si tratta? L’espressione allude alla crescente tendenza di aziende ritenute molto inquinanti di provare a ripulire un’immagine compromessa attraversi sponsorizzazioni di eventi dello sport, magari insieme con aziende del settore sportivo. E’ evidente che qui il tema si fa ancora più complicato, non potendosi ragionevolmente richiedere ad un’azienda del settore sportivo di vigilare su sponsorizzazioni provenienti da altri ambiti produttivi. Peraltro, prendiamo nota anche di questa tendenza, e accendiamo un campanello di attenzione anche sui compagni di viaggio.
In conclusione, è necessario investire nel miglioramento degli impatti ambientali delle nostre aziende e comunicare correttamente, senza timori di quanto realizzato.
Questa è e sarà la strada per il successo.
Articolo di Luciano Butti – B&P Avvocati (www.buttiandpartners.com) per Assosport